di Francesco Sylos Labini
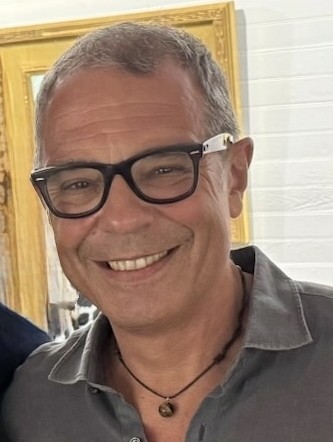
Secondo il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó, i suoi omologhi europei “si trovano in uno stato di psicosi militarista (…) e l’Unione europea
non sembra interessata alla possibilità che il vertice di pace di Budapest, proposto da Trump e Putin, possa effettivamente portare alla pace. A giudicare dai discorsi di oggi – ha aggiunto – devo concludere che un numero significativo di politici europei farà di tutto, persino l’impossibile, per impedire che questo vertice si svolga fin dall’inizio”.
Siamo così giunti a una situazione paradossale: i leader europei non solo si oppongono a un piano di pace concreto, ma addirittura all’idea stessa che i presidenti delle due principali superpotenze nucleari possano incontrarsi per cercare una via di dialogo.
Eppure, non è sempre stato così. Nella lunga e complessa sequenza di eventi che ha condotto all’invasione illegale – ma in larga misura provocata – da parte della Russia, uno snodo cruciale fu il vertice Nato di Budapest del 2008.
In quell’occasione, l’amministrazione americana guidata da George W. Bush spinse affinché all’Ucraina e alla Georgia fosse offerta una prospettiva concreta di adesione alla Nato.
Angela Merkel adottò allora una linea più prudente, intuendo che quella promessa, dal punto di vista di Putin, equivaleva a una vera e propria “dichiarazione di guerra”. Anche Nicolas Sarkozy manifestò estrema cautela rispetto a quella decisione. Oggi i ruoli sembrano essersi invertiti: mentre da Washington arrivano segnali – deboli ma reali – di apertura al dialogo, sono le cancellerie europee a ostacolare ogni tentativo. Perché? Cosa è cambiato?
Dagli anni Novanta, l’economia europea ha subito un processo di profonda trasformazione: da sistema produttivo basato sulla manifattura e sui beni reali, si è evoluta in un’economia dominata dalla finanza, in particolare americana e britannica. Questa finanziarizzazione ha investito anche la politica, che si è allineata agli interessi del sistema finanziario, fino a esserne direttamente influenzata. José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea nel 2014, è oggi presidente non esecutivo e consulente di Goldman Sachs. Mario Draghi è stato vicepresidente di Goldman Sachs Europe, Emmanuel Macron ha iniziato la sua carriera nella banca d’affari Rothschild. Friedrich Merz, cancelliere tedesco, è stato presidente del consiglio di sorveglianza di BlackRock Germany.
Questi sono alcuni dei volti dell’élite tecnocratica che starebbe operando nell’interesse pubblico. Come sia stato possibile che tale narrazione si sia radicata così profondamente nell’opinione pubblica è questione complessa.
Ma è certo che abbiano pesato il progressivo indebolimento della libertà di stampa e la crisi profonda della scuola e dell’università.
Basti pensare, senza che l’Italia rappresenti un’eccezione, alla diffusione nel linguaggio educativo dei concetti di “debito” e “credito formativo”, ormai presenti fin dalla scuola media.
Le continue riforme del sistema educativo sono affidate ai “tecnici” di Bankitalia, che ne plasmano ogni aspetto in funzione delle esigenze del sistema economico dominante – ovvero quello finanziario.
La finanza, dunque, non si limita a condizionare le scelte economiche: seleziona direttamente i protagonisti della politica, determinandone orientamenti e priorità e plasma l’orientamento dell’intera società.
Si prenda ancora BlackRock: oltre a investire nel debito pubblico italiano acquistando titoli di Stato, è anche tra i principali azionisti di aziende strategiche come Eni, Enel e Intesa Sanpaolo.
Come può un primo ministro ignorare gli interessi di una delle tre principali società finanziarie al mondo?
Non è un caso se Giorgia Meloni, eletta in opposizione a Mario Draghi, abbia finito per replicarne – o addirittura superarne – le politiche.
Il legame tra debito e guerra è tutt’altro che metaforico.
Nei Paesi occidentali, il debito pubblico e privato ha ormai raggiunto livelli strutturalmente insostenibili.
In questo contesto, la sopravvivenza dell’impero finanziario sembra basarsi su una logica di espansione permanente, finalizzata all’acquisizione di nuove risorse, secondo schemi che ricordano da vicino quelli degli antichi imperi coloniali.
Oggi l’Ucraina e la Russia sono i nuovi teatri di questa strategia.
Ma è proprio la guerra in Ucraina a segnare simbolicamente la fine dell’epoca della supremazia occidentale.
E se nei nostri Paesi lo sfruttamento continua, alimentato dall’assuefazione e dall’apatia di un’opinione pubblica disorientata, nel resto del mondo – dove vivono 8 miliardi di persone – sta emergendo, lenta ma inesorabile, la consapevolezza che esiste un’alternativa alla trappola del debito infinito e auto-rigenerante.
Fonte: pagina Facebook di Francesco Sylos Labini, 29 ottobre 2025

0 commenti